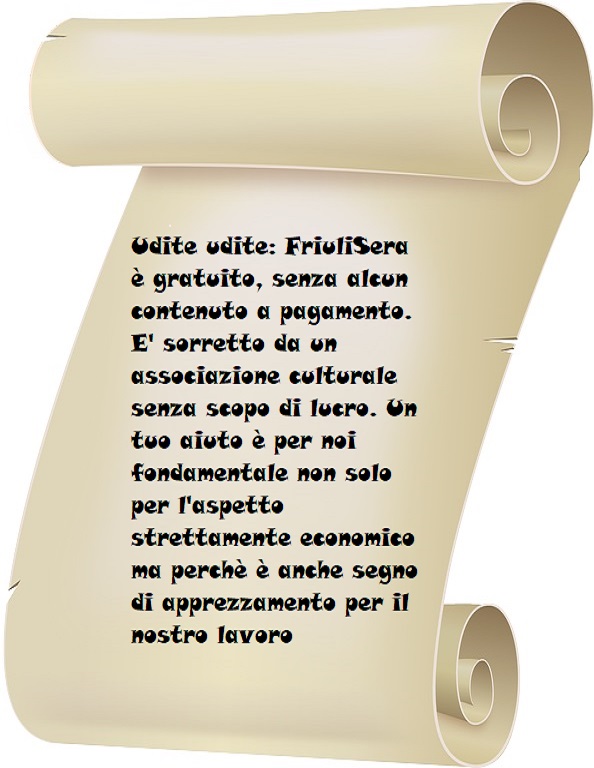Usa, Cina, Russia e Aquisgrana: succedono cose…..
Breve premessa. Che la seconda guerra fredda fosse ripartita esattamente da dove si “concluse” la prima è un fatto oramai conclamato. Correva l’anno 1990 e Gorbaciov, in cambio del suo nulla osta alla riunificazione tedesca, ottenne una rassicurazione sia da parte del cancelliere Kohl che del segretario di stato statunitense James Baker sul fatto che la Nato si sarebbe fermata li dov’era, ossia in Germania. Quella promessa, suggellata purtroppo soltanto da una farlocca stretta di mano, si trasformò nella più clamorosa pernacchia diplomatica della storia… Gorbaciov infatti mantenne la parola data mentre la Nato iniziò la sua cavalcata a spron battuto verso est e il resto del mondo… Dissoltosi il nemico giurato (senza colpi di coda militari di alcun tipo) la Nato in teoria si sarebbe potuta sciogliere a sua volta, si sarebbe potuta chiudere una fase storica estremamente conflittuale e se ne sarebbe potuta aprire una nuova, fatta di distensione, disarmo e cooperazione internazionale. Ma la marea nordatlantica non si ritirò, anzi si riorganizzò in funzione di una propria proiezione globale (con la professionalizzazione delle forze armate dei Paesi alleati) a dimostrazione postuma che il carattere difensivo dell’alleanza era, come molti denunciavano fin dall’inizio, solo un pretesto. Oggi, dopo trenta anni dalla caduta del muro di Berlino, la Nato è arrivata, armi e bagagli, a ridosso dei confini della Russia, raggiungendo l’apice di una nuova “guerra fredda” fuori tempo e rilanciando la corsa agli armamenti (nucleari e non). Il problema è che oggi, nonostante l’indiscussa supremazia militare che gli Stati Uniti continuano ad usare con la leggerezza di un rinoceronte impazzito, le economie dei “blocchi” sono infinitamente più compenetrate ed interdipendenti mentre il mondo è diventato senza dubbio multipolare. Nel mezzo di questi trenta anni l’occidente atlantico ha rispolverato la vecchia (e stantia) missione civilizzatrice: col pretesto della esportazione democratica e con cordate a geometria variabile ha rilanciando il suo sistema predatorio e neocoloniale bombardando, occupando, destabilizzando e rapinando una lunga lista di Paesi. Il suprematismo “politically correct” alla base di questo modello di politica estera belligerante ha attraversato tutti i governi occidentali di centro-destra così come di centro-sinistra ed anzi con una particolare zelanteria vistosamente esibita da parte di questi ultimi. A riprova di ciò basti pensare che se la Cina è diventata anch’essa un nemico designato per i formidabili interessi statunitensi, con tanto di (autolesioniste) guerre commerciali scatenate dal presidente Trump, lo si deve alla dottrina “pivot to Asia” lanciata dalla presidenza del democratico e premio Nobel per la pace Barak Obama. Vedremo se gli accordi distensivi recentemente presi “a voce” al summit G20 di Osaka tra Usa da una parte e Russia e Cina dall’altra avranno un seguito concreto. Certo è che il blocco dei dazi e la luce verde per Huawei (per la componentistica non legata alla sicurezza) in cambio di investimenti e consumi cinesi per l’agro-business a stelle e strisce dimostrano che al presidente Trump qualcuno (tra cui lo stesso WTO) ha spiegato che sono proprio gli Stati uniti ad essere la parte più lesa tra i due contendenti della guerra commerciale da lui stesso scatenata.
 Tre settimane prima di Osaka…
Tre settimane prima di Osaka…
Il 5 giugno scorso, a Mosca, Vladimir Putin e Xi Jinping hanno firmato 30 accordi intergovernativi e commerciali e ben due dichiarazioni congiunte sullo sviluppo del partenariato russo-cinese e sull’equilibrio strategico internazionale. Alleati per forza o per necessità indotta dal neo-protezionismo statunitense che si è sommato alla storica aggressività militare, sta di fatto che Russia e Cina hanno decisamente serrato i ranghi dopo decine di incontri di avvicinamento avvenuti negli ultimi anni. A fronte di uno scambio commerciale che valeva 108 miliardi di dollari nel 2018 (+ 25% rispetto al 2017) le due superpotenze prevedono di investire almeno 22 miliardi nei prossimi anni per realizzare i trenta progetti sottoscritti il 5 giugno. La gran parte di questi progetti è incentrata sullo sviluppo e diversificazione delle forniture energetiche (petrolio e gas). La Russia, già primo fornitore di petrolio in Cina, sarà probabilmente in grado di raggiungere tale primato anche per ciò che riguarda il gas naturale attraverso due nuovi gasdotti e nuovi grandi impianti per la produzione di gas liquefatto. Tra gli accordi non mancano progetti congiunti su aerospazio e settori ad alta tecnologia, imponenti progetti infrastrutturali (stradali, fluviali, ferroviari e marittimi) e non ultimo, l’intenzione di utilizzare le monete nazionali (rublo e yuan) nelle transazioni finanziarie e negli scambi per arrivare a soppiantare, in prospettiva, il dollaro. Completano il quadro di questa epocale integrazione tra le due superpotenze due dichiarazioni congiunte di portata globale: da una parte l’impegno ad integrare la Via della Seta cinese con l’Unione economica eurasiatica russa con lo scopo “di formare in futuro una più grande partnership eurasiatica”; dall’altra lavorare congiuntamente per il rafforzamento della “stabilità strategica globale”. Su quest’ultimo punto Putin e Jimping sono entrati nel merito senza mezze parole: denuncia del ritiro unilaterale Usa dal trattato INF e della conseguente intenzione di schierare missili nucleari a raggio intermedio a ridosso di Russia e Cina; “richiamo” per quei Paesi europei che pur aderendo al medesimo trattato attuano missioni nucleari congiunte in ambito Nato (come l’Italia) ospitando al contempo ordigni nucleari sul proprio territorio; denuncia della decisione Usa di non ratificare il trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari.
Il rischio evidente è che queste decisioni unilaterali degli Stati Uniti rilancino la corsa agli armamenti nucleari e la stessa possibilità di un conflitto definitivo.
Putin e Jinping hanno inoltre ufficializzato la loro stretta vicinanza di posizionamento su alcuni dossier come Iran, Venezuela, Siria e Corea del Nord. I due presidenti, in particolare, si sono detti favorevoli al riavvio di un dialogo tra Usa e Corea del Nord e alla stabilizzazione della situazione in Venezuela. Questo incontro tra le due superpotenze il 5 giugno scorso deve avere in qualche modo dimostrato tutta la sua deterrenza se lo stesso Trump, al G20 di Osaka, ha fatto qualche passo indietro sulla guerra commerciale con la Cina, ha dichiarato di volere una distensione con la Russia, per poi volare a stringere la mano al presidente nord coreano… Lo scatto fotografico conclusivo del G20 di Osaka è comunque al tempo stesso grottesco ed esemplificativo: contornati da una splendida cornice floreale stanno incravattati e sorridenti i capi dei governi che rappresentano l’80% del Pil mondiale e le rispettive multinazionali di bandiera (e/o di Stato), con al centro Mohammed bin Salman, giovane monarca assoluto saudita…
E allora l’Europa?
il 13 novembre 2017, a Bruxelles, 23 Paesi Ue (poi saliti a 25) hanno firmato il protocollo PESCO, la cosiddetta “Cooperazione Strutturata Permanente”,. Questa iniziativa, prevista dal Trattato di Lisbona e mai intrapresa prima a causa della ritrosia del Regno Unito, è stata celebrata come un primo passo verso un sistema integrato di difesa comune. Ma è proprio così? Partiamo dal dato più ovvio: perché si possa davvero parlare di difesa comune sarebbe utile partire da una politica estera comune, la quale evidentemente non esiste e con buona probabilità non esisterà mai nell’attuale contesto politico. L’Europa è infatti un’aggregazione di stati che condividono moneta e ideologia liberista ma in politica estera tendenzialmente ognuno fa per sé. Ogni Paese ha infatti le sue minime o estese aree di influenza e relativi interessi, spesso in conflitto o in competizione con quelli degli altri, che vengono difese seguendo uno schema neocoloniale e di stretto “interesse nazionale”. Ogni Paese poi ha la sua (più o meno) sviluppata industria nazionale degli armamenti e sue proprie direttici di sviluppo dello strumento militare, direttrici che sono strutturalmente legate all’assorbimento della produzione della propria stessa industria. Il cuore della PESCO è una lista di 20 punti contenuti nell’omonimo protocollo. Il primo di questi punti richiede l’aumento del budget da dedicare alle spese militari. A seguire una lista di direttive rispetto alle quote di budget da dedicare alla ricerca e sviluppo di sistemi d’arma sia di interesse “nazionale” che di interesse comunitario. Solo due dei venti punti indicati nel protocollo fanno riferimento ad impegni legati a disponibilità e dispiegamento di truppe in un quadro comune. Si tratta tuttavia di un invito ai paesi che già non lo abbiano fatto di costituire il proprio battle group (1500 uomini) e di renderlo disponibile per il turno semestrale di stand-by nel quadro EU-BG (due battle group per semestre).
In sintesi ciò che l’Europa ha messo in campo a partire dal 2005, e che ha confermato con la PESCO, sono al massimo tremila uomini divisi in due battle group in attesa di essere impiegati in una qualche missione. Per completare il quadro va detto che in quattordici anni di dottrina EU-BG nessun battle group è mai stato impiegato in guerra ed anzi qualche annata ha visto persino latitare almeno una delle quote previste…
Questo semplice dato potrebbe far pensare che i Paesi europei (compreso il nostro) siano in realtà pacifici ed abbiano abbandonato le loro pulsioni belligeranti ma la storia degli ultimi vent’anni dimostra al contrario che gli stessi Paesi, mentre hanno tenuto parcheggiati a turno i loro soldati nel EU-BG, hanno partecipato e continuano a partecipare in ordine sparso a tutte le guerre d’aggressione targate NATO.
Non solo, dal 2002 hanno anche trovato le risorse per inquadrare i propri soldati nella NATO Response Force (NRF), una forza di reazione rapida costituita da 20.000 effettivi, pronta per l’impiego e proiettabile in ogni angolo del pianeta in tre giorni.
La PESCO, in concreto, è il prodotto di un compromesso tra Francia e Germania più Spagna e Italia in quanto gruppo di Paesi dell’eurozona più popolosi e rilevanti dal punto di vista militare (operatività e tecnologia).
Tale gruppo promotore, in cui ovviamente risulta egemone lo storico asse franco-tedesco, si è materializzato a Versailles in un insolito vertice nel marzo 2017. A margine del vertice in questione, l’allora presidente francese Francois Hollande chiarì con parole inequivocabili il senso dell’incontro: “…Non vogliamo solo commemorare i Trattati di Roma, ma affermare insieme l’impegno per il futuro. Francia, Germania, Italia Spagna hanno la responsabilità di tracciare la strada; non per imporla agli altri ma per essere una forza al servizio dell’Europa che dà impulso agli altri (…) La Difesa è un argomento scientemente evitato dai Trattati di Roma. Oggi l’Europa può invece rilanciarsi con la Difesa, per garantirsi la sicurezza, essere attiva a livello globale, cercare le soluzioni ai conflitti che la minacciano. Questa deve essere, in coerenza con l’impegno Nato, la nostra priorità…”.
Sullo sfondo di queste dichiarazioni si muovono accordi commerciali esclusivi, forniture di sistemi d’arma, multinazionali di bandiera e soldati che ne garantiscono, certificano ma soprattutto difendono l’esito.
Questo classico schema neocolonialista è il vero centro della difesa europea – “ognuno per sé”, congiuntamente al sostegno diretto al comparto industriale militare made in Europe …Non certo il diritto internazionale, il multilateralismo o l’Onu indicati nella grottesca premessa del protocollo PESCO come contesti di riferimento.
Anzi è già chiaro come la stessa PESCO sia soltanto l’ennesimo campo di battaglia, ben finanziato, su cui si confronteranno le industrie belliche nazionali (e rispettivi governi di riferimento).
Il vero esercito europeo c’è già e, al momento, parla francese e tedesco…
Aquisgrana: se prima eravamo in quattro, adesso siamo in due…
“…Francia, Germania, Italia e Spagna hanno la responsabilità di tracciare la strada…” dichiarava Hollande al vertice di Versailles del marzo 2017.
Oggi sono rimasti in due, quelli di sempre, quelli che contano veramente, quelli che hanno recentemente accelerato verso un’integrazione economica, politica e militare senza precedenti.
Il 22 gennaio scorso, ad Aquisgrana, Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno superato (rilanciandolo) lo storico accordo firmato da De Gaulle e Adenauer lo stesso giorno nel lontano 1963.
Nel preambolo al nuovo trattato e nelle dichiarazioni a margine della firma dello stesso, emerge quasi ossessivamente la chiara intenzione di dissimulare con lo spirito europeista la blindatura integrata dei propri interessi nazionali. In sostanza ciò che viene ufficialmente detto è che Germania e Francia hanno “dovuto” siglare questo trattato per salvare l’Europa dai sovranismi e dai nazionalismi e per rilanciarne la moneta, il mercato unico e naturalmente i “valori”.
Il trattato di Aquisgrana è composto da 28 articoli suddivisi in 7 capitoli:
1) Affari europei; 2) Pace, sicurezza, sviluppo; 3) Cultura, istruzione e ricerca; 4) Cooperazione regionale e trans frontaliera; 5) Sviluppo sostenibile, clima e affari economici; 6) Aspetti organizzativi.
Nel primo breve capitolo viene assunto l’impegno tra i due Paesi a stabilire consultazioni regolari a tutti i livelli prima dei principali vertici europei con lo scopo di convergere sulle decisioni da prendere o sulle proposte da fare. La recente nomina del ministro della Difesa tedesco Ursula von der Leyen a capo della Commissione europea e di Christine Lagarde a capo della Bce sono stati senza dubbio un buon banco di prova per questo aspetto del trattato.
Nel secondo capitolo si dichiara che gli interessi dei due Paesi in materia di sicurezza sono “indivisibili”: verrà ulteriormente rafforzata la cooperazione tra le rispettive forze armate per permettere spiegamenti congiunti e la cooperazione tra le rispettive industrie belliche anche in funzione dell’export di sistemi d’arma sviluppati in comune.
In questa direzione verranno sviluppati programmi di difesa comuni prevedendo una loro estensione ad eventuali altri partner (come, ad esempio, il progetto per un nuovo caccia di sesta generazione a cui la Spagna ha già chiesto di aderire).
Verrà costituita una unità militare congiunta da utilizzare per operazioni di “stabilizzazione” in Paesi terzi.
In particolare nel continente africano dove Francia e Germania intendono costruire una “sempre più stretta collaborazione” rafforzando la “cooperazione” nel settore privato, nell’integrazione regionale, nel “buon governo” e gestendo la prevenzione dei conflitti, il peacekeeping e le situazioni post-conflitto.
Verrà quindi istituito un Consiglio di Difesa e Sicurezza franco-tedesco quale organo di direzione congiunta rispetto agli impegni presi e che si riunirà regolarmente ai massimi livelli.
Sarà inoltre costruita una stretta collaborazione tra i rispettivi ministeri degli Esteri e le rappresentanze diplomatiche comprese quelle presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite per il quale viene avanzata una esplicita richiesta di riforma affinché si possa attribuire alla Germania un seggio permanente alla stregua di Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito e Francia. Quest’ultimo punto in particolare è considerato “prioritario” per la diplomazia franco-tedesca.
Nel terzo capitolo viene premuto l’acceleratore sulla integrazione dei sistemi educativi, degli istituti culturali, dei media, della ricerca attraverso la promozione dello studio delle due lingue, del reciproco riconoscimento delle qualifiche, dello sviluppo di specifici programmi di interscambio e piattaforme digitali.
Nel quarto capitolo viene affrontato il tema delle zone trans frontaliere dove i due Paesi intendono sostenere le rispettive minoranze linguistiche (specialmente quella tedesca), il bilinguismo e la cooperazione attraverso progetti trans frontalieri legati a mobilità, salute, energia, economia col preciso intento di mantenere “alti gli standard nei campi della legislazione del lavoro, sicurezza sociale e protezione ambientale”.
Per realizzare questi obiettivi si punterà sullo sviluppo delle autonomie locali riunite in “eurodistretti” che verranno dotati di specifiche competenze e risorse finanziarie.
Nel quinto capitolo, dopo una breve dichiarazione d’intenti rispetto alla promozione e sostegno degli accordi globali sul cambiamento climatico, Francia e Germania dichiarano la ferma intenzione di inserire questo aspetto in ogni settore chiave della loro cooperazione.
Si parla espressamente di “transizione energetica” attraverso progetti congiunti nel campo delle infrastrutture, delle energie rinnovabili e più in generale della efficienza energetica.
Viene istituito un Consiglio di Economia e Finanze franco-tedesco per promuovere l’”armonizzazione bilaterale” a livello normativo e la competitività delle rispettive economie.
In questo quadro, oltre ad un alto organo consultivo composto da dieci esperti di economia “indipendenti”, verrà istituito un Forum franco-tedesco per coinvolgere i così detti “portatori d’interesse” e gli “attori rilevanti” nei processi di trasformazione delle due società.
Nel sesto capitolo viene stabilito che gli incontri tra i governi dei due Paesi dovranno tenersi almeno una volta ogni tre mesi. Il nascituro Consiglio dei ministri franco-tedesco adotterà una agenda pluriennale di progetti la cui implementazione sarà monitorata da appositi “Commissari per la Cooperazione franco-tedesca”.
Almeno una volta ogni tre mesi, a rotazione, un rappresentante del governo di uno dei due Paesi assisterà al Consiglio dei ministri dell’altro Paese.
I Consigli, le strutture e gli strumenti della cooperazione franco-tedesca verranno sottoposti a verifiche periodiche e ad eventuali aggiustamenti.
C’è quasi tutto in questo trattato tranne ovviamente ciò di cui si è discusso a “porte chiuse” e tutti quelli che sono i “non detti” impliciti. E non è poco.
Ripulendo infatti questa operazione dai riferimenti al potenziamento della “cooperazione europea”, al multilateralismo, alla stessa integrazione nella Nato, quello che appare evidente è che questo trattato (più gli annessi “non detti”) sancisce un passaggio epocale nella collocazione geopolitica dei due Paesi coinvolti, non a caso dopo la Brexit.
Rispetto agli Stati uniti il messaggio è piuttosto chiaro: stiamo nella Nato ma intendiamo sviluppare autonome capacità militari sia tecnologiche che di proiezione oltre confine e non siamo più disposti ad accettare l’unilateralismo degli interessi strategici statunitensi.
“La politica degli anni ’80 non aiuterà a far fronte alle questioni di oggi” ha dichiarato lo scorso dicembre Il capo della diplomazia tedesca Heiko Maas per sostenere l’indisponibilità della Germania a schierare sul proprio territorio i missili nucleari statunitensi a medio e corto raggio. Più in generale lo stesso Maas si è dichiarato contrario al dispiegamento di tali missili in Europa dopo l’annunciato ritiro unilaterale degli Stati Uniti dal Trattato (INF).
La Germania si sta quindi delicatamente defilando dalla “protezione” nucleare a stelle e strisce ed è quasi ovvio che il nuovo ombrello, dopo Aquisgrana, sarà la Force de Frappe francese magari con future integrazioni, collaborazioni e sostegni finanziari da parte tedesca.
Dal punto di vista militare la Germania non porta con sé una grande dote di operatività ma di sicuro una certa “buona volontà” dimostrata dalla recente integrazione nella Bundeswehr di due brigate olandesi, una ceca e una romena, da un bilancio della difesa in crescita, dall’addestramento al bombardamento nucleare nel quadro NATO, da una industria bellica di tutto rispetto, dalla presenza in Mali di proprie truppe e mezzi.
Da parte sua la Francia, oltre alla Bomba, alla sua straripante industria “della difesa” e al potere di veto all’Onu, dispone di basi, avamposti e pezzi di “territorio nazionale” in diversi continenti ed oceani con conseguenti spiccate capacità di proiezione della forza militare.
Macron ha ereditato da Hollande il rilancio del protagonismo francese nel continente africano. Parigi intende infatti consolidare la presenza militare in Africa dalla Costa Atlantica fino all’Oceano Indiano, dal Senegal a Gibuti, passando per il Sahel e quindi ricongiungersi con altre basi e avamposti già presenti nei due oceani.
Questa visione strategica espansionista, aggressiva e molto ambiziosa richiede un concorso negli “oneri per la sicurezza” che la Germania offre già da anni.
La capacità di proiezione globale (condivisa come piattaforma con gli alleati) offre all’industria bellica francese prospettive senza fine.
Il ruolo di capofila richiede però alla Francia (e a tutti i francesi) un forte aumento della spesa militare: con la nuova Legge di Programmazione Militare ( LPM 2019-2025), Macron ha stanziato la somma di 295 miliardi di euro, ben 105 miliardi in più rispetto al quinquennio precedente.
L’8 febbraio dello scorso anno, nel presentare la LPM il ministro della difesa Parly ha giustificato questo forte aumento definendolo “…necessario per mantenere l’influenza globale della Francia ed intervenire in ogni luogo del globo in cui vengano minacciati gli interessi della Nazione e la stabilità internazionale…”.
Il piano ha l’ambizione di garantire “l’autonomia strategica” nazionale ed “europea”. Oltre alle nuove acquisizioni (sommergibili nucleari, fregate, droni, satelliti, aerei ed elicotteri) la LPM prevede un corposo aumento del personale: 6.000 unità per le forze armate di cui 1.500 per i servizi segreti e 1.000 operatori per la cybersicurezza più 750 funzionari da impiegare nella “divisione vendite” nella Direction Générale de l’Armement.
In Francia infatti è lo stesso governo ad occuparsi dell’export dei prodotti dell’industria bellica nazionale, dalle pistole ai caccia…
Anche se dal punto di vista militare il matrimonio di Aquisgrana appare del tutto sbilanciato non dimentichiamoci che la Germania porta con sé il treno economico delle sue esportazioni (specialmente verso i mercati russo e cinese), enormi capacità finanziarie, il controllo esclusivo del flusso di gas russo che soddisfa attualmente quasi un terzo della domanda europea attraverso i gasdotti del Baltico.
Il banchetto nuziale è decisamente ricco se aggiungiamo a tutto ciò la partita del così detto Franco africano CFA, oggi convertito in euro, ma la cui finanza generata/estorta passa attraverso le banche francesi.
Rispetto all’Europa il messaggio è altrettanto chiaro: o con noi o con gli Stati uniti. Appare chiaro che con Aquisgrana è stato formalizzato, nero su bianco, un fatto storicamente assodato: Francia e Germania sono l’Europa. Il resto sono Paesi satellite che potranno decidere se aggregarsi alla cordata in via esclusiva o giocando su due staffe con la sponda statunitense (Paesi di Visegrad e Italia…).
Parliamo di Paesi, di Stati perché sono ancora questi la realtà materiale delle relazioni internazionali. E poco conta se dagli anni novanta si sia astrattamente creduto ad una presunta “fine degli Stati” a fronte dei fenomeni di globalizzazione e finanziarizzazione. Nella grande maggioranza dei casi, gli Stati stanno semplicemente dismettendo la loro funzione regolatrice per concentrarsi sulla funzione repressiva interna e di proiezione militare verso l’esterno in piena sintonia con la natura stessa del capitalismo storicamente inteso.
Lo schema neocoloniale, in sintesi, rappresenta la versione aggiornata e perfezionata del colonialismo e dell’imperialismo novecenteschi: multinazionali di bandiera e grandi banche > ricerca scientifica e tecnologica > professionalizzazione delle forze armate > controllo dei mercati, della forza lavoro e delle materie prime.
Si è di fatto passati a piè pari dalla “civilizzazione” della Belle epoque alla “democratizzazione” post ’89 e la Francia, in questo senso, è stata grande maestra.
Tutto ciò appare come un vicolo cieco, in un mondo multipolare “controllato” da superpotenze, medie potenze, piccole potenze sulla pelle della maggior parte degli esseri umani e dello stesso pianeta che ci ospita.
Eppure le variabili in gioco sono molteplici a cominciare dalla stessa composizione del capitalismo che non è un monolite ma è attraversato spesso da interessi divergenti anche all’interno dei singoli “sistemi-Paese”.
Se si parla di “Europa” ma soprattutto di un’altra Europa risulta allora necessario uscire dal provincialismo per entrare nel merito di queste relazioni materiali, facendo i conti con le interdipendenze globali per cominciare ad occuparsi seriamente di politica estera.
Risulta necessario abbandonare sia l’europeismo senza sostanza (perché gli Stati, come abbiamo visto, esistono eccome!) che l’unilateralismo delle uscite in solitaria da questa Europa perché da soli ci si schianta comunque o peggio, si diventa definitivamente una carcassa da fare a pezzi.
L’unico spazio politico europeo dove sarebbe possibile ed opportuno prendere reale coscienza dello stato di fatto ed elaborare un nuovo spirito costituente su basi alternative, condivise, concrete, è il gruppo della Sinistra Europea (GUE/NGL).
Per quanto contraddittorio e ridimensionato dalle recenti elezioni europee, risulta essere l’unico raggruppamento che si è sempre opposto al liberismo costituente della Unione Europea, del Fondo monetario internazionale e della stessa Bce.
Ma rivendicare una Europa sociale, oggi, non può più bastare. Il dibattito sul “che fare” dovrebbe ripartire da Aquisgrana, dalle nuove vecchie faglie di scontro globale e dalla chiara intenzione dei governi francese e tedesco di fare, in questo contesto, da capofila di un rinnovato assetto belligerante e neocoloniale continentale.
Uscire dalla NATO e dalla melma del neocolonialismo di marca “europea” è una prospettiva incredibilmente tortuosa ma che dovrebbe essere posta come base comune per qualsiasi futuro condiviso e condivisibile di una qualsiasi “altra” Europa.
Un futuro che ci consenta di imboccare una direzione opposta a quella oggi in campo: la strada del disarmo progressivo, della cooperazione, della mutualità nell’interdipendenza, della stabilità, della conversione energetica e produttiva.
Un tale futuro può essere immaginato e costruito soltanto da chi parla la stessa lingua: quella della giustizia sociale, della pace e solidarietà tra i popoli.
Gregorio Piccin